È morto il vignettista Giorgio Forattini, con la sua satira graffiò i potenti di Roma

È morto Giorgio Forattini, il disegnatore che più di ogni altro ha dato un volto — anzi, una smorfia — alla politica italiana. Aveva 94 anni e si è spento a Milano, lontano ma non troppo dalla Roma che per decenni fu il suo teatro d’azione satirica. Nato nel 1931 nella capitale, Forattini ha attraversato da protagonista mezzo secolo di storia nazionale armato solo di una matita e di un’ironia tagliente. Da Paese Sera a Repubblica, da La Stampa a Il Giornale, le sue vignette sono state il riflesso più pungente del potere, il ritratto impietoso e veritiero dei vizi della classe dirigente.
La satira come servizio pubblico
La satira di Forattini non faceva sconti, né a destra né a sinistra. Craxi, Berlusconi, Prodi, Andreotti, tutti finirono sotto la lente del suo umorismo corrosivo. Le sue vignette, spesso pubblicate in prima pagina, non erano semplici disegni: erano editoriali illustrati, capaci di dire in un tratto quello che mille parole non osavano scrivere. E in un Paese dove la satira è spesso tollerata solo quando colpisce “gli altri”, Forattini aveva scelto la via più rischiosa: colpire tutti.
Con la sua matita trasformava la politica in un teatro dell’assurdo, denunciando ipocrisie e compromessi con la leggerezza del riso e la precisione del chirurgo.
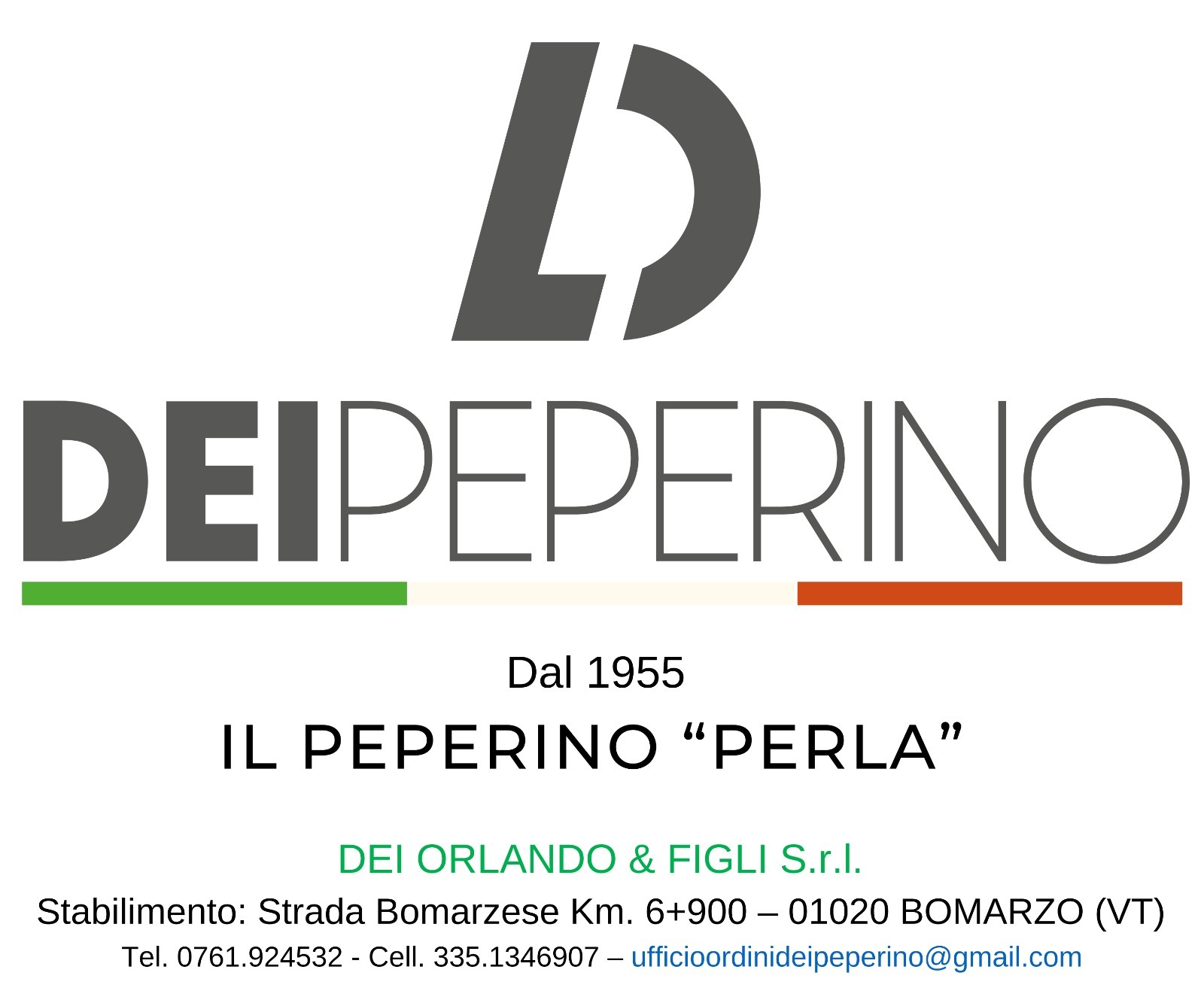
L’uomo che cambiò il linguaggio dei giornali
Quando nel 1973 Paese Sera e Panorama pubblicarono le sue prime vignette a colori, la satira politica in Italia cambiò forma. Per la prima volta un disegnatore diventava presenza fissa e autorevole sulle prime pagine, non come riempitivo ma come voce autonoma. La celebre vignetta del 1974 — la bottiglia di champagne che celebra la vittoria dei “no” al referendum sul divorzio, con il tappo-Fanfani che vola via — segnò una rivoluzione di linguaggio.
Forattini aveva capito che il giornale poteva essere anche un palcoscenico visivo. Le sue caricature non erano mai gratuite: ogni tratto era un messaggio politico, ogni risata un atto d’accusa.
Un percorso irregolare, da autodidatta curioso
Non era un artista “di scuola”. Dopo il liceo, Forattini studiò architettura e teatro, lavorò come operaio e rappresentante di commercio, poi come pubblicitario per Fiat e Alitalia. Solo a quarant’anni entrò nel mondo del giornalismo, vincendo un concorso per disegnatori indetto da Paese Sera. Da autodidatta, portò nel mestiere la visione concreta di chi aveva conosciuto la vita vera, quella fuori dalle redazioni.
Forse è per questo che la sua satira non fu mai elitaria: parlava al pubblico, non alle élite. Era un artigiano dell’ironia, capace di trasformare l’attualità in immaginario collettivo.
La Roma di Forattini e i suoi potenti
Forattini fu romano nell’anima e nello sguardo. Le sue vignette raccontavano il potere come lo si vede nei bar e nelle strade della capitale: con sarcasmo, affetto e rabbia insieme.
Roma era il centro del potere, e Forattini ne disegnava i riti come un cronista popolare armato di matita. I corridoi di Montecitorio, i salotti del centro, i palazzi ministeriali: tutto diventava un circo di facce note, riconoscibili e ridicole.
Non a caso, in molti politici vedevano in lui un avversario temuto più di un editorialista. Bastava una vignetta per cambiare il tono di una giornata politica, per smascherare con un sorriso quello che la stampa “seria” taceva.
Il lascito: la libertà di ridere del potere
Con la sua morte, l’Italia perde non solo un grande vignettista ma un simbolo di libertà d’espressione. In un’epoca in cui la satira rischia di essere imbrigliata nel politicamente corretto o strumentalizzata da appartenenze ideologiche, il suo esempio resta attuale: la satira serve solo se è libera.
Forattini non cercava consenso: cercava verità attraverso il riso. È questo che lo ha reso scomodo, e perciò necessario.
Oggi, chi graffia ancora i potenti?
Nel tempo in cui le vignette si consumano sui social e le parole pesano come mine, la lezione di Forattini appare ancora più urgente.
Non bastano le celebrazioni postume se si dimentica che la sua forza stava nell’autonomia e nel coraggio di offendere il potere quando tutti tacevano. Forattini non era tenero, non era accomodante: era libero.
E in un’Italia che tende a premiare i conformisti, il suo sorriso storto resta una forma di resistenza civile.
Perché finché c’è qualcuno che ride dei potenti, la democrazia respira.
