Fiumicino, dopo 11 anni (di burocrazia) si chiude la bonifica Eni: 30mila litri di cherosene finiti su terreno agricolo

Ci sono voluti più di undici anni di burocrazia, carte bollate e lavori, affinché il Comune di Fiumicino potesse scrivere la parola fine sulla bonifica del terreno agricolo contaminato dal cherosene fuoriuscito da un oleodotto Eni nel novembre del 2014 e destinato all’aeroporto. Un’odissea ambientale iniziata con una perdita di circa 30mila litri di carburante per jet, sversati su un’area coltivata a poche decine di metri dall’autostrada Roma-Civitavecchia, nella zona nord della città.
Undici anni di carte, scavi, monitoraggi, analisi e rinvii. Il 3 ottobre 2025 il Comune di Fiumicino ha ricevuto il certificato di avvenuta bonifica del sito, restituendo ai cittadini un terreno dichiarato “idoneo” secondo i parametri ambientali previsti dal decreto legislativo 152/2006. Ma resta una domanda che aleggia come il cherosene disperso nell’aria quella notte del 2014: perché tutto questo è durato così tanto?
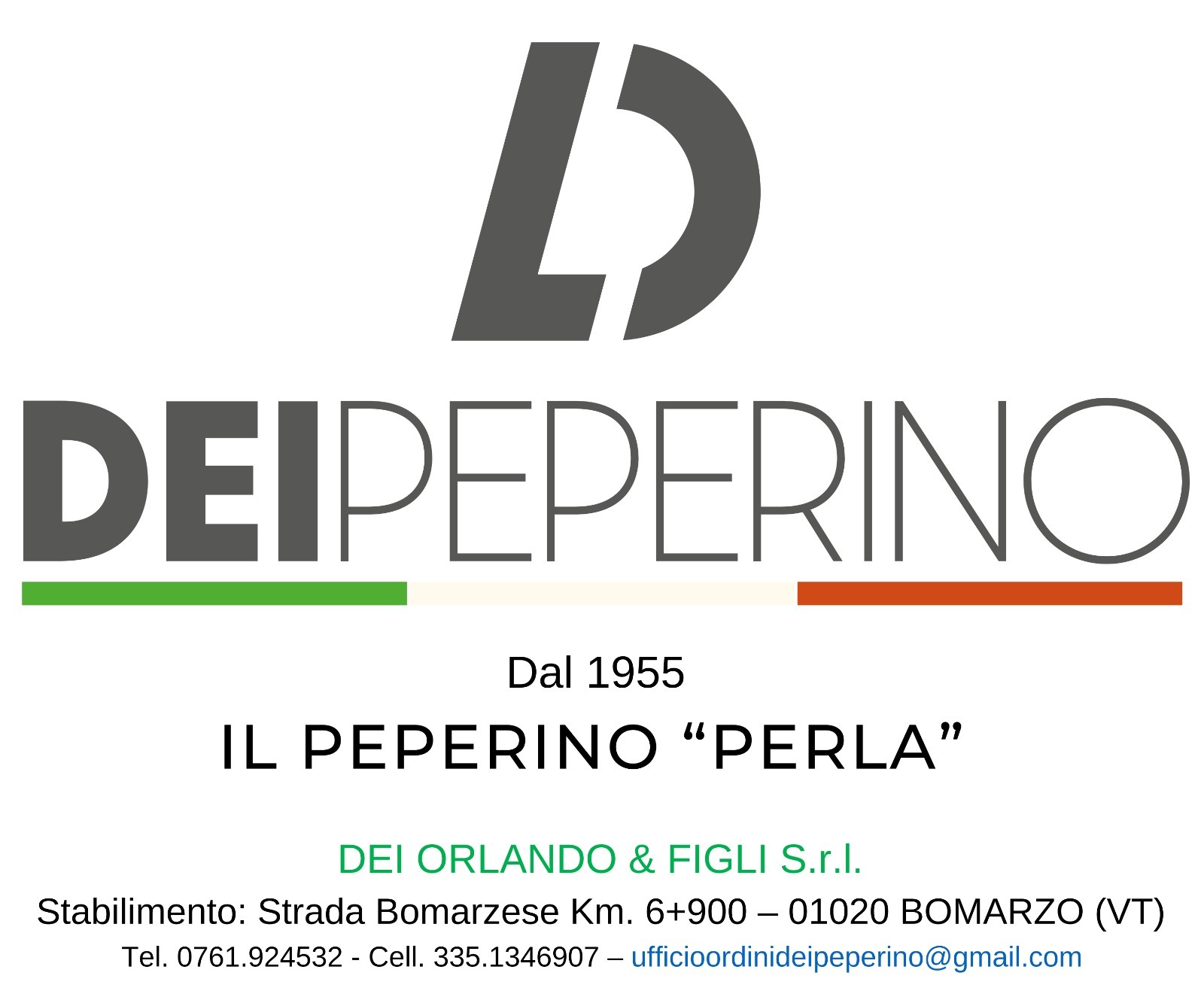
Fiumicino, la notte dell’effrazione
Tutto comincia nel novembre del 2014. Sulla linea dell’oleodotto Eni, all’altezza di una palina di controllo, a Fiumicino nord, qualcuno — rimasto ignoto — provoca un’effrazione dolosa nel tubo. Dal punto di rottura, un fiotto di cherosene si riversa nei terreni agricoli e nelle acque del vicino Rio Palidoro, contaminando suolo e falda.
La società Eni interviene subito, interrompe il flusso, scava, ripara, piazza barriere assorbenti. Le operazioni di “messa in sicurezza d’emergenza” riescono a contenere i danni peggiori, ma il terreno resta impregnato di idrocarburi. Da lì parte un percorso amministrativo e tecnico che si trasformerà in un labirinto: un mosaico di monitoraggi, relazioni e collaudi che si estenderà per oltre un decennio.
Un’inchiesta senza colpevoli
L’inchiesta sull’origine dell’effrazione non porta a nulla. Il responsabile — come scriveranno anni dopo gli uffici competenti — “risulta ignoto”. Nessuno paga per l’inquinamento e la stessa Eni si dichiara “soggetto non responsabile della contaminazione”.
Tocca comunque al colosso energetico avviare e finanziare le complesse operazioni di bonifica, in quanto proprietario dell’infrastruttura. La società mette in campo scavi profondi, monitoraggi del suolo e delle acque, impianti di emungimento e tecniche di “bioremediation”, utilizzando composti ossidanti a lento rilascio per degradare gli idrocarburi residui.
Una bonifica che sulla carta avrebbe dovuto durare poche settimane, forse al massimo qualche mese, ma che in realtà si è trascinata fino al 2025. Tra richieste di integrazioni, collaudi parziali, aggiornamenti normativi e continui rimpalli tra enti.
Dieci anni di attese e monitoraggi sui terreni di Fiumicino
Dal 2015 al 2024, il sito viene sottoposto a una fitta serie di campionamenti da parte di ARPA Lazio, che certifica progressivamente la conformità dei terreni e delle acque. I primi risultati positivi arrivano già nel 2018, ma serviranno altri sei anni per completare i monitoraggi “post-operam”.
Nel frattempo, la società trasmette relazioni su relazioni: piani di caratterizzazione, analisi di rischio, cronoprogrammi, rapporti tecnici. Ogni documento deve essere validato da più enti, ogni passaggio attende il parere formale di ARPA o del Comune. In un sistema amministrativo in cui la prudenza diventa paralisi, la bonifica procede a passo di lumaca.
Terreni bonificati, ma le domande restano
Nel luglio 2024, la relazione tecnica di fine bonifica dichiara che i terreni e le acque di falda sono conformi ai limiti di legge. L’anno successivo, ARPA Lazio conferma che “le attività di scavo e di rimozione del terreno contaminato possono considerarsi ultimate”.
Il 3 ottobre 2025 arriva la certificazione ufficiale: il terreno agricolo è finalmente libero da residui tossici. Eppure, nessuno spiega perché un processo di verifica — tecnicamente concluso nel 2018 — abbia impiegato altri sette anni per ottenere un timbro.
Il mistero del ritardo resta tutto lì, nei faldoni dell’amministrazione, tra richieste di planimetrie, protocolli, coordinate geografiche e scambi di PEC.
Una burocrazia infinita, a Fiumicino, specchio del sistema Italia
La cronologia degli atti racconta un’Italia lenta, troppo lenta, intrappolata nei suoi stessi procedimenti. Ogni documento apre un nuovo passaggio, ogni firma richiede un’altra firma. Mentre il sito veniva monitorato per confermare ciò che già si sapeva — che l’inquinamento era stato eliminato — il procedimento restava formalmente aperto per anni, bloccato da adempimenti marginali.
Un ritardo che non trova giustificazioni ambientali né tecniche. Forse prudenza, forse inerzia amministrativa? Forse semplice disattenzione verso un terreno agricolo, lontano dai riflettori, ma non dal diritto alla tutela ambientale.
Un epilogo a metà, per Fiumicino: troppo tempo per una ‘semplice’ bonifica
Oggi il Comune di Fiumicino può dire di aver chiuso la partita: la bonifica è conclusa, il suolo è di nuovo sicuro. Ma resta l’amaro di un processo interminabile, un simbolo di come, in Italia, anche un intervento ambientale urgente possa impantanarsi in un mare di carte.
Un episodio che si chiude senza colpevoli, ma non senza interrogativi. Perché undici anni per restituire alla collettività un terreno privato pulito restano troppi. E in questa vicenda — più che l’effrazione nel tubo — a fare danni è stato soprattutto il troppo tempo.
