“Nun c’è trippa pe’ gatti”: la vera storia dietro il proverbio più famoso di Roma

“Nun c’è trippa pe’ gatti” non è solo un modo di dire colorito del dialetto romano. È il frutto di una scelta concreta, precisa, presa nel cuore della macchina amministrativa capitolina oltre un secolo fa. A pronunciare (anzi, a scrivere) quella frase fu Ernesto Nathan, sindaco di Roma tra il 1907 e il 1913.
Un uomo che, analizzando i conti del Comune, decise di cancellare la spesa destinata alle frattaglie per i gatti randagi impiegati come derattizzatori negli archivi pubblici. Da lì, nacque un’espressione che oggi è diventata un modo di chiudere ogni discorso con realismo e ironia: quando non c’è più nulla da dare, “nun c’è trippa pe’ gatti”.
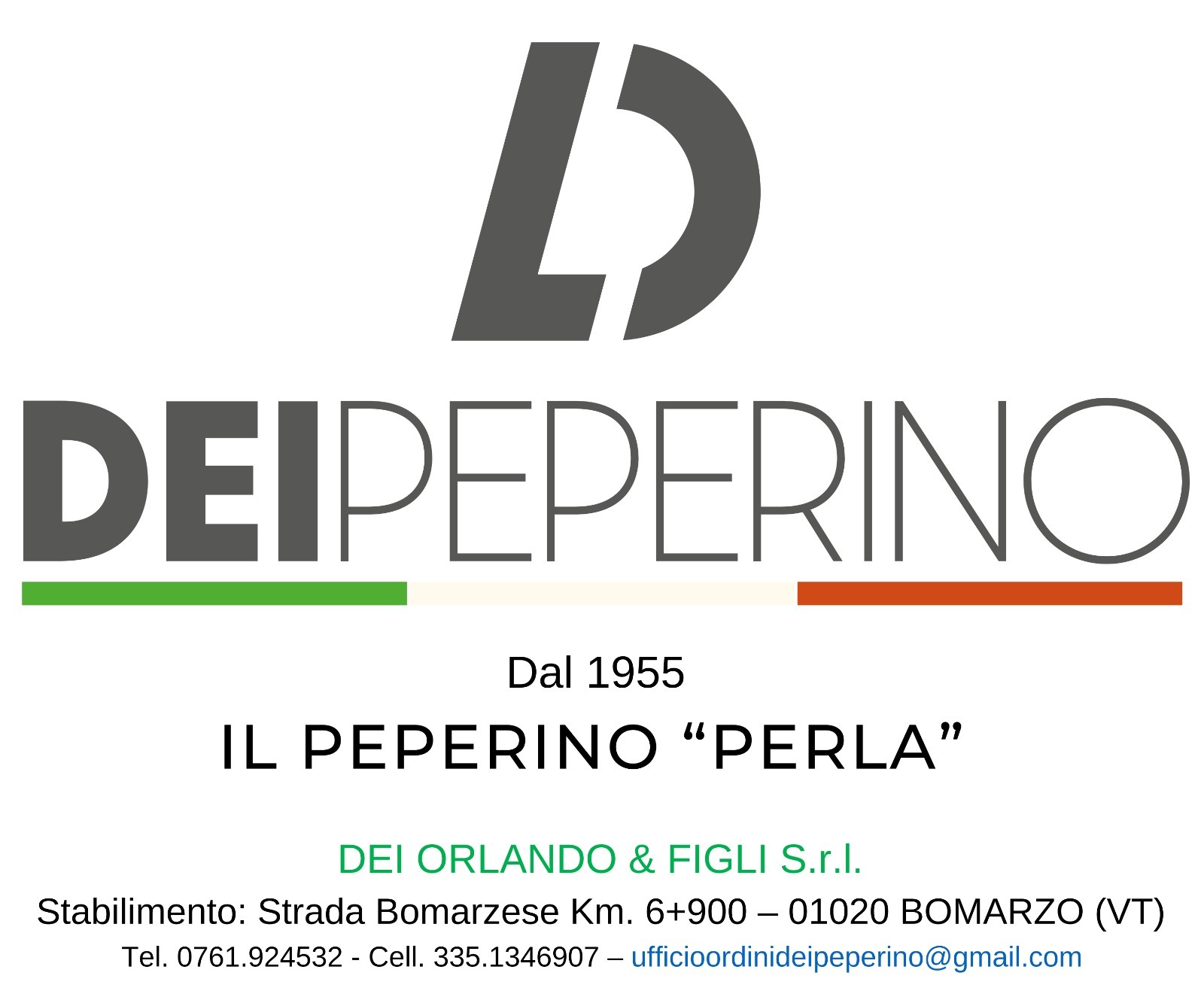
I gatti romani come derattizzatori ufficiali del Comune
Roma, primi del Novecento. Il Campidoglio, come tutte le grandi istituzioni, è un luogo vivo, pieno di documenti, carte e… topi. Per tenerli sotto controllo, il Comune aveva trovato una soluzione del tutto naturale: gatti randagi lasciati liberi negli archivi, abili cacciatori silenziosi e instancabili. Per “ricompensarli” del servizio, l’amministrazione stanziava una voce a bilancio chiamata “frattaglie per gatti”.
Una spesa modesta, tutto sommato, ma che non sfuggì all’attenzione del nuovo sindaco. Nathan, repubblicano, massone e laico rigoroso, non era tipo da lasciarsi intenerire. Quando si trovò davanti quella voce di bilancio, la considerò inutile, se non addirittura un esempio mascherato di clientelismo o cattiva gestione delle risorse. Tagliò la voce senza esitazioni e scrisse accanto, in tono definitivo: “Nun c’è trippa pe’ gatti”.
Non era solo un appunto. Era una dichiarazione di principio. Nessun privilegio, nemmeno per i felini più utili. Da quel gesto, apparentemente marginale, nacque un’espressione che è sopravvissuta a guerre, crisi, cambi di potere e che oggi è ancora attualissima.
“Nun c’è trippa pe’ gatti”, un proverbio che parla di realtà
Dopo quel gesto, la frase “nun c’è trippa pe’ gatti” cominciò a diffondersi. Prima tra i dipendenti comunali, poi tra i cittadini, quindi sui giornali. Diventò in poco tempo il modo più diretto e schietto per dire che non c’è più nulla da concedere, né risorse né favori. Oggi si usa in politica, in economia, nella vita quotidiana. Lo si dice al collega che chiede un aumento, al figlio che chiede la paghetta, al politico che promette l’impossibile.
Ma non è solo una frase che chiude una porta. È anche un inno alla resilienza, alla dignità, all’arte di arrangiarsi. Come quei gatti romani, privati della “trippa” ufficiale, ma capaci di continuare a cacciare, sopravvivere e vivere liberi. In fondo, è un proverbio che parla della gente comune, di chi va avanti senza aiuti, senza sconti, contando solo sulle proprie forze.
Ernesto Nathan: un sindaco che ha fatto della sobrietà una battaglia morale
La frase diventata proverbio non sarebbe esistita senza il carattere e le idee di Ernesto Nathan. Figura unica nel panorama politico dell’epoca, era un amministratore inflessibile, anticlericale e modernizzatore. Il suo obiettivo era uno solo: una Roma laica, trasparente, efficiente. La sua lotta contro gli sprechi fu costante e concreta. E in quella battaglia rientrava anche il taglio alle frattaglie per i gatti.
Il gesto non fu solo simbolico. Era parte di un progetto di razionalizzazione e rigore, in cui ogni spesa doveva avere un senso, un’utilità pubblica dimostrabile. Quella frase a margine del bilancio rappresenta il cuore del suo pensiero amministrativo: se non serve davvero, si elimina. Anche se si tratta di gatti.
Gatti e gattare: la resistenza silenziosa nella Roma di ieri e di oggi
A Roma, i gatti non sono mai stati semplici animali. Sono parte del paesaggio urbano, simboli di indipendenza e resistenza. Dalle rovine dell’antica Roma ai cortili delle periferie, hanno sempre trovato il modo di cavarsela, anche quando la trippa è finita. Non a caso, le colonie feline, come quella celebre di Torre Argentina, sono diventate vere e proprie istituzioni.
Al loro fianco, le gattare, custodi silenziose e testarde, che ogni giorno portano cibo, affetto e dignità. In fondo, il detto “nun c’è trippa pe’ gatti” non è mai stato un invito alla rassegnazione, ma una sfida all’autonomia. Se non arriva l’aiuto dall’alto, ci si organizza dal basso.
Un detto che resta attuale: tra crisi, tagli e nuove povertà
Nel contesto attuale, in cui ogni giorno si parla di crisi economica, aumento del costo della vita, tagli alla spesa pubblica, “nun c’è trippa pe’ gatti” suona più vero che mai. Non è una frase per scoraggiare, ma per ricordare la necessità di guardare in faccia la realtà. Non sempre ci sono risorse da distribuire, e chi vuole qualcosa deve spesso guadagnarselo o trovarselo da solo.
Ma il proverbio, nella sua forma ruvida, porta con sé anche un insegnamento profondo: chi non si arrende, chi si adatta, chi è capace di cavarsela, trova sempre il modo di andare avanti. Come i gatti di Roma, affamati ma mai sconfitti.
Un’eredità linguistica che resiste al tempo
Oggi, la frase è presente nei titoli dei giornali, nei dibattiti politici, nelle chiacchiere da bar. Ha superato il dialetto per diventare un’espressione nazionale, riconoscibile ovunque. Ma la sua forza è ancora tutta romana: cruda, diretta, ironica. E, soprattutto, vera.
“Nun c’è trippa pe’ gatti” non è nostalgia, ma memoria attiva. È la voce di un popolo che ha sempre saputo far fronte alla scarsità con l’ingegno, al potere con la battuta, all’abbandono con la solidarietà. E se oggi i gatti di Roma continuano a girare liberi tra rovine e sampietrini, è anche perché nessuna frase, neanche quella, li ha mai fermati davvero.
