Politica e trasparenza: l’ossimoro di un sistema che si racconta limpido mentre affonda nel caos
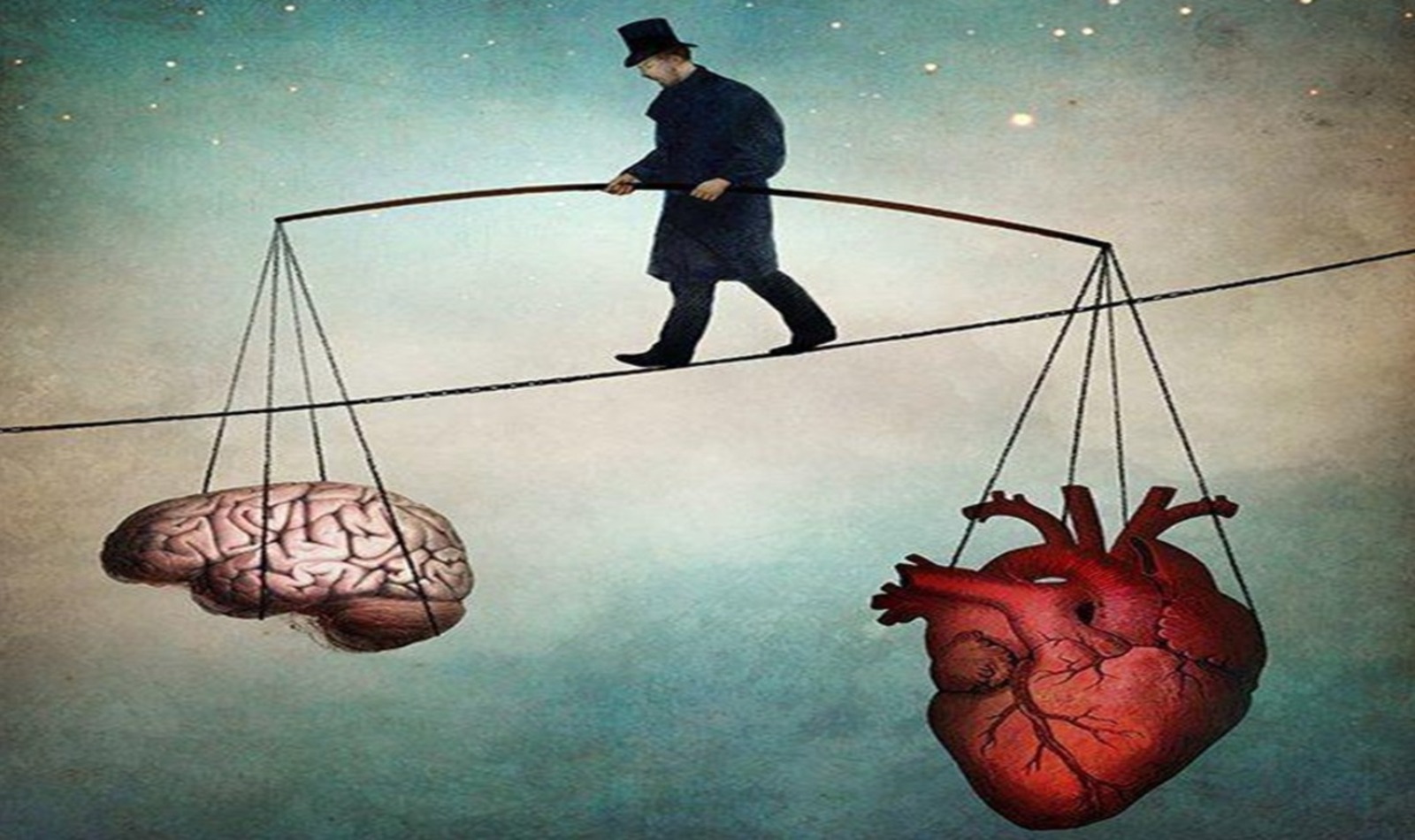
Dimissioni, polemiche, scambi di accuse, nomine controverse e una comunicazione frammentata: nel panorama politico italiano, la trasparenza resta spesso solo una parola vuota. E il cittadino paga il prezzo della confusione. In un tempo in cui la parola “trasparenza” viene brandita da ogni leader politico come simbolo di integrità, le azioni che ne seguono sembrano raccontare una realtà opposta. La politica italiana si muove tra nebbie comunicative, spostamenti strategici di poltrone, dimissioni lampo e nuove nomine discutibili, mentre nei palazzi del potere e sui social media regna un linguaggio ambiguo, a tratti contraddittorio, che rende difficile distinguere tra fatti e propaganda. Massimo Catalucci, giornalista e osservatore critico delle dinamiche socio-politiche, ci conduce in un’analisi articolata e profonda della condizione attuale del Paese, tracciando una riflessione che va oltre l’attualità per toccare le fondamenta morali ed etiche della nostra società.
Il paradosso della trasparenza
In apparenza, la trasparenza è al centro della narrazione politica. È il cavallo di battaglia di ogni nuovo governo, di ogni amministratore locale, di ogni candidato in cerca di fiducia popolare. Ma quando lo sguardo si posa sulle dinamiche reali – sugli scambi di accuse, sulle giravolte partitiche, sulle dichiarazioni incoerenti – emerge un quadro ben diverso: quello di un sistema che sembra muoversi in direzione opposta alla chiarezza. Non è un caso se oggi le parole chiave sono “dimissioni”, “trasferimenti politici”, “polemiche sui media”, “informazione distorta”. A queste si aggiunge una crescente incapacità comunicativa da parte delle istituzioni, che spesso parlano più per slogan che per contenuti, generando solo ulteriore confusione e sfiducia.
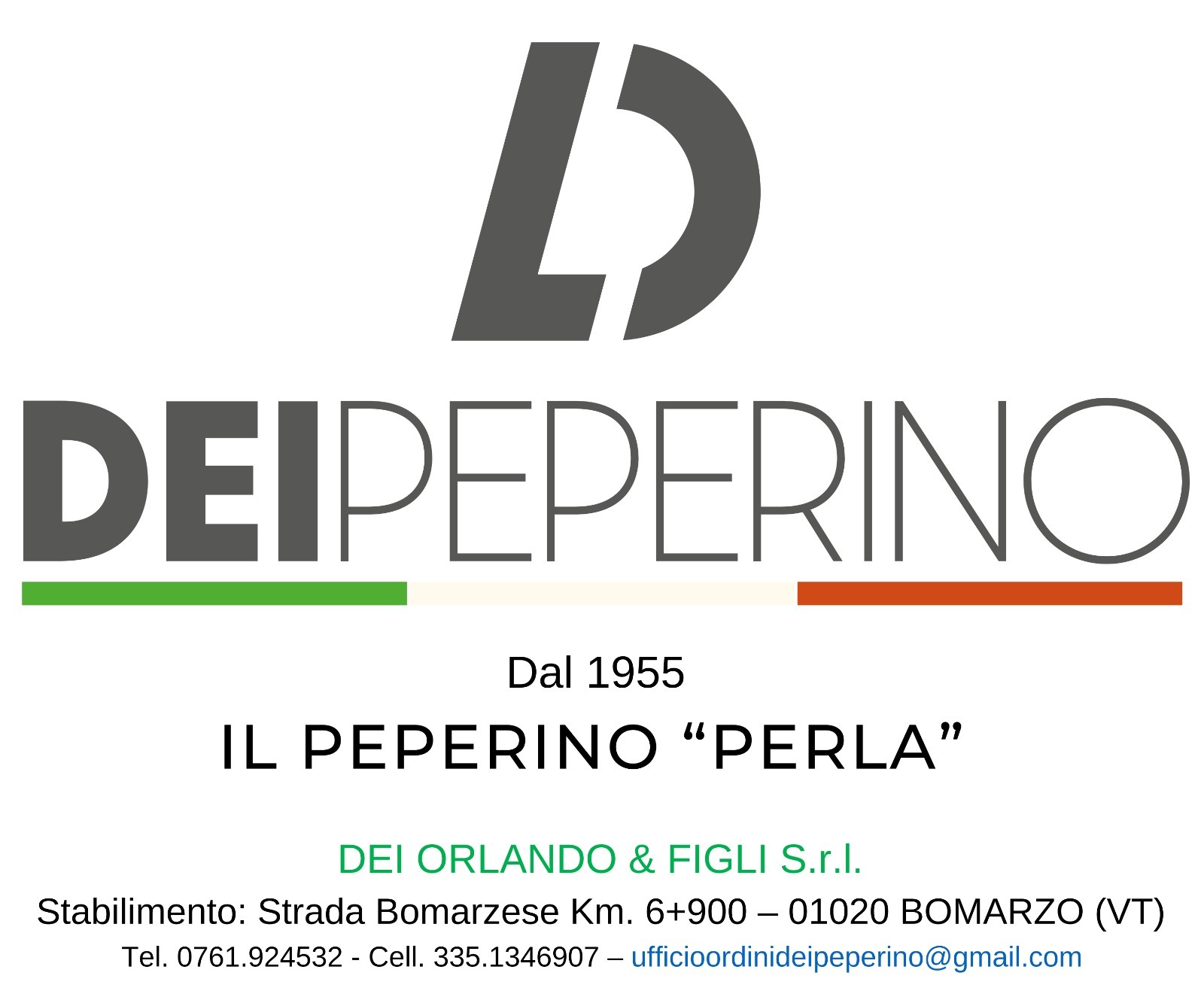
Coerenza e congruenza
Nel suo editoriale, Catalucci introduce due concetti fondamentali: coerenza e congruenza, spesso considerati sinonimi, ma in realtà ben distinti. La coerenza riguarda la logica interna tra ciò che si pensa, si dice e si fa. La congruenza, invece, coinvolge l’integrità più profonda dell’individuo, il suo allineamento tra emozioni, pensieri e comportamenti. È proprio questa assenza di congruenza a spingere la politica verso un baratro comunicativo. Inseguire il consenso a ogni costo significa adeguarsi a un sistema che premia la strategia, non la sostanza, l’obbedienza ai gruppi di potere, non la preparazione o la competenza. Ne deriva un sistema dove a ricoprire ruoli chiave non sempre sono le persone più adeguate, ma quelle più “malleabili”.
Il sistema che esclude chi non si adegua
Catalucci descrive la politica italiana come un imbuto selettivo: largo in ingresso, ma stretto in uscita. Chi vuole fare politica viene accolto con grandi promesse di partecipazione e cambiamento. Ma solo chi accetta le regole non scritte del sistema riesce a emergere. Gli altri, quelli che insistono sull’etica, la preparazione e la trasparenza reale, vengono tagliati fuori. Così, la macchina pubblica si riempie di figure che rispondono più agli equilibri di potere interni che agli interessi dei cittadini. E a pagarne le conseguenze è proprio la società civile, che si ritrova sempre più distante, esclusa e confusa.
Morale ed etica: pilastri dimenticati
Alla base di questa deriva c’è il disallineamento tra morale ed etica. La morale, dice Catalucci, è il nostro riferimento ai valori universali; l’etica, invece, è il modo in cui questi valori si traducono nella vita quotidiana. Ma quando le azioni dei rappresentanti pubblici tradiscono questi principi, il sistema si destabilizza. Nel rumore assordante della comunicazione politica, spesso mancano riferimenti etici chiari, manca una direzione condivisa. La politica perde la sua funzione originaria di servizio alla collettività e diventa strumento di affermazione personale, di successo individuale, di potere autoreferenziale.
Dall’individuo alla società
Catalucci rilancia una riflessione centrale: la trasformazione della società passa dal cambiamento individuale. Solo se ogni persona si interroga sul proprio equilibrio tra pensiero, parola e azione, sarà possibile costruire una comunità fondata su relazioni sane, trasparenti e collaborative. Nel contesto attuale, però, anche a livello locale, le amministrazioni faticano a costruire un dialogo chiaro con i cittadini. Le informazioni si perdono, si distorcono, arrivano incomplete o fuorvianti. E dove manca comunicazione, cresce il muro tra istituzioni e cittadinanza, tra chi governa e chi dovrebbe essere rappresentato.
Trasparenza vera o caos garantito?
In un’epoca in cui la trasparenza viene rivendicata ma raramente praticata, il rischio è quello di legittimare una politica dell’ambiguità, dove parole e azioni viaggiano su binari separati. Eppure, una vera rigenerazione democratica non può che partire da un ritorno alla coerenza, alla congruenza, alla morale e all’etica, non come concetti astratti, ma come pilastri concreti dell’agire pubblico. L’alternativa? Continuare a navigare in un sistema che, mentre promette chiarezza, genera solo confusione. E dove il cittadino, sempre più disilluso, osserva da spettatore un teatro politico che ha smesso da tempo di parlare il suo linguaggio.
