Roma, troppi allagamenti: “93 casi estremi in 10 anni, il doppio di Milano”

Roma è la “capitale” degli allagamenti: 93 eventi meteo estremi in dieci anni, più del doppio di Milano ferma a 40. Lo certifica il Rapporto Città Clima 2025 di Legambiente, che piazza la Capitale in cima alla classifica nera degli impatti urbani del clima che cambia. Quasi la metà degli episodi sono allagamenti dovuti a piogge intense e improvvise: un fenomeno diventato routine, con strade trasformate in fiumi e sottopassi trappole. Un dato su tutti: gli eventi estremi censiti a Roma rappresentano l’11,5% del totale nazionale. Numeri che non sono solo statistiche: descrivono disservizi quotidiani, danni economici, scuole chiuse, bus deviati, famiglie in difficoltà.
Il contesto meteo
La fotografia arriva proprio nei giorni di nuova allerta: su Roma e sul Lazio è scattata l’allerta gialla per venerdì 7 novembre. Non è un caso: gli episodi violenti si concentrano sempre più fuori stagione, con celle temporalesche brevi ma dirompenti. In città, un millimetro di pioggia non è uguale ovunque: su suoli impermeabilizzati e sistemi di drenaggio datati, la stessa precipitazione produce effetti molto diversi. Per questo il monitoraggio delle allerte e la prevenzione locale fanno la differenza tra un acquazzone e un’emergenza.
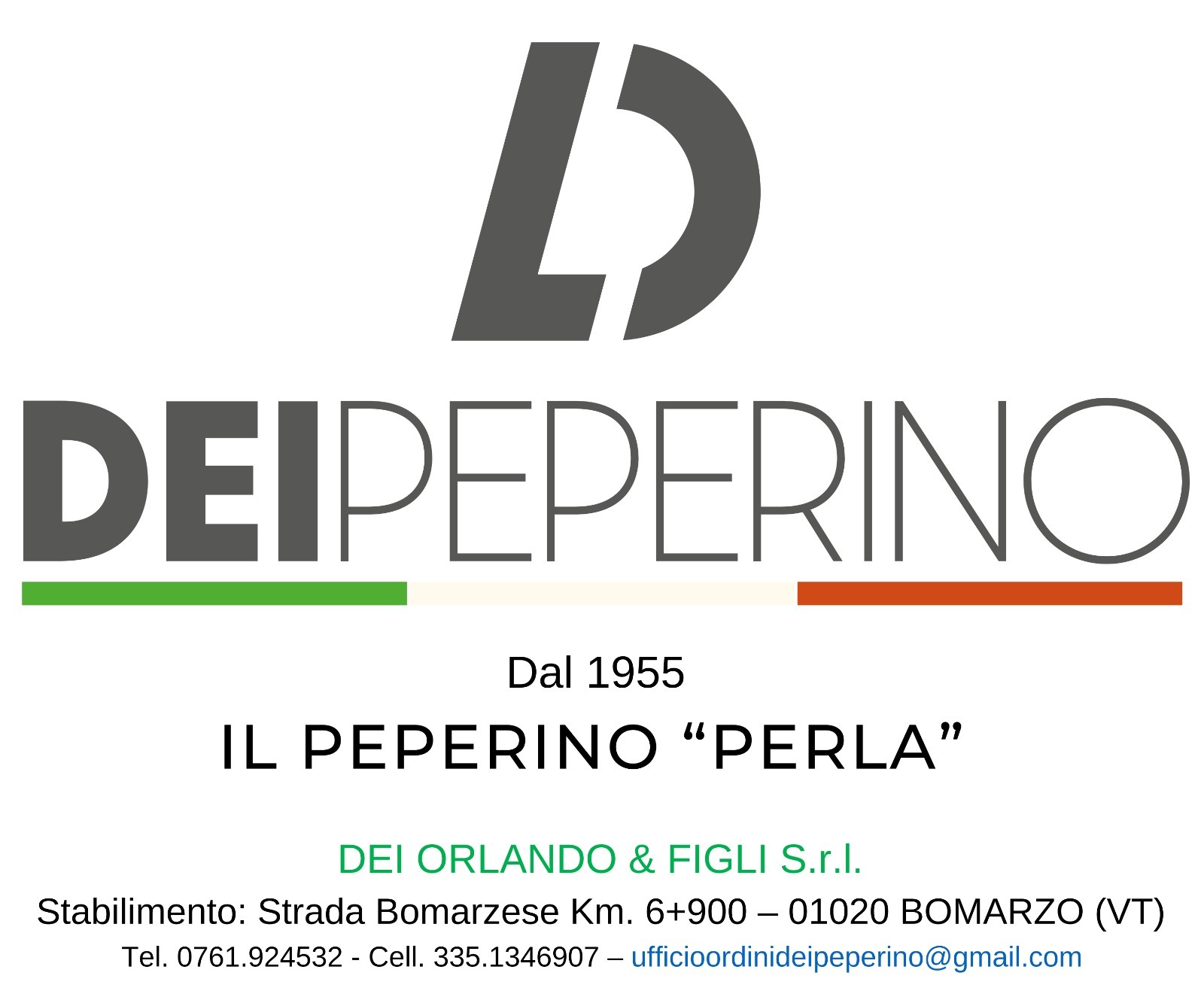
I numeri, senza sconti
Nel dettaglio, dal 2015 ad oggi Roma ha contato 54 allagamenti da piogge intense. A questi si sommano 12 episodi di danni da vento, 12 casi di danni alle infrastrutture, 3 esondazioni fluviali, 3 grandinate, 1 evento di siccità prolungata, 1 danno al patrimonio storico, 1 episodio di temperature record e 6 mareggiate. È una mappa delle fragilità urbane: strade e sottoservizi sotto stress, litorale esposto, patrimonio artistico vulnerabile. Non è solo un problema di “troppa acqua”: è il combinato disposto di infrastrutture invecchiate, suolo impermeabile e ondate meteo più estreme.
Le ragioni strutturali
Per Legambiente, Roma paga due conti: l’estensione sterminata e il consumo di suolo. «Abbiamo visto nascere prima quartieri e pesanti urbanizzazioni, poi un diluvio di enormi hangar della logistica», osserva Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Ogni nuova superficie asfaltata toglie spazio all’acqua per infiltrarsi nel terreno e aumenta la velocità con cui finisce in fogna e in strada. È il cosiddetto “effetto scivolo”: l’acqua corre, trascina detriti, intasa caditoie, allaga in pochi minuti i punti più bassi.
La strategia c’è, ma va accelerata
Un punto fermo: a gennaio 2025 il Comune ha approvato la Strategia di Adattamento. Il documento definisce priorità chiare: mitigare gli eventi meteorici violenti, garantire l’approvvigionamento idrico, adattarsi alle temperature crescenti, proteggere la linea di costa dall’erosione. Non è una bacchetta magica: gli effetti si vedranno nel medio-lungo periodo. Ma la direzione è giusta se si passa rapidamente dai principi ai cantieri, puntando su drenaggio urbano sostenibile, vasche di laminazione, rinaturalizzazione dei fossi e manutenzione programmata.
Mobilità, il nodo che sblocca tutto
Scacchi mette il dito nella piaga: «Ridurre le emissioni significa ridurre drasticamente il numero di automobili, accompagnando il cambiamento con nuovi tram, metro e scelte coraggiose». Roma “divorata” dalle auto è anche una città più calda e impermeabile: asfalto e parcheggi moltiplicano isole di calore e superfici rigide. La marcia indietro sulla Fascia Verde ha congelato una transizione necessaria. Senza un taglio del traffico privato, gli interventi di adattamento rischiano di correre col freno tirato.
Le priorità operative (subito)
Pubblica utilità significa interventi utili domani mattina: pulizia e mappatura delle caditoie nei punti a rischio; piani di emergenza per sottopassi e scuole; sensori di livello e barriere mobili nei nodi critici; manutenzione dei corsi d’acqua minori; sportelli per micro-interventi condominiali (grondaie, cortili drenanti, raccolta acque). A scala urbana: marciapiedi “spugnosi”, aiuole di bioretenzione, alberature per ombra e assorbimento, parcheggi permeabili. Tutto documentato e tracciabile con open data, così i cittadini possono verificare dove e quando si interviene.
Cosa possono fare i cittadini
Nell’immediato, informarsi e prevenire. Iscriversi ai canali ufficiali di Protezione Civile e Roma Capitale; evitare scantinati, sottopassi e piani interrati durante i temporali; non sostare vicino ad alberi e cantieri; pulire griglie e pluviali privati; segnalare caditoie o fossi ostruiti. In caso di allerta, preparare un “kit meteo” in casa e in auto (torcia, power bank, mantella, scarpe impermeabili) e pianificare percorsi alternativi. Semplici abitudini che, quando l’acqua sale, fanno la differenza.
Energia, rifiuti, quartieri: la svolta che serve
Legambiente indica tre cantieri permanenti: rinnovabili diffuse (fotovoltaico su tetti pubblici e privati), gestione corretta dei rifiuti (per ridurre ostruzioni e degrado urbano), sviluppo deciso del trasporto pubblico locale. Aggiungiamo una leva spesso sottovalutata: i patti di quartiere per il clima. Micro-progetti cofinanziati e misurabili—una scuola drenante, un giardino della pioggia, un viale alberato—possono trasformare le strade in infrastrutture ambientali. Ogni intervento conta se fa rete e diventa standard.
Roma nel mondo che cambia
Mentre in Brasile si apre la Cop30, la Capitale ha l’occasione di passare da simbolo di vulnerabilità a laboratorio di adattamento. Gli accordi globali valgono se le città—dove vive la maggioranza delle persone—tagliano emissioni e mettono in sicurezza i cittadini. Roma ha competenze, università, imprese, associazioni: servono governance stabile, cronoprogrammi pubblici, indicatori di risultato e rendicontazione annuale. Perché gli allagamenti non diventino l’ennesima normalità, ma il promemoria di una trasformazione possibile.
Conclusione: dall’emergenza alla manutenzione del futuro
I 93 casi in dieci anni dicono che il tempo degli annunci è finito. Adattamento e mitigazione sono due facce della stessa politica urbana: meno auto, più verde e suoli permeabili; meno consumo di suolo, più cura dell’esistente; meno emergenze, più manutenzione intelligente. Se Roma accetta la sfida, la prossima pioggia non sarà un incubo ricorrente, ma un test superato da una città più sicura, vivibile e giusta.
